|
Segnalati da
Roberto Lupia
Il
castello di Belcastro
di Pino
RENDE
(pubblicato su La Provincia KR
nr. 24/2003)
L’età
dei castelli
Simbolo del potere
signorile, e segnale
dell’avvento di una nuova
organizzazione urbana che si
concretizza, prevalentemente,
attraverso l’arroccamento nelle
aeree dell’interno
(“Incastellamento”), agli inizi
del sec. X, il castellum
(1)
costituisce la forma
d’insediamento che caratterizza
i nuovi centri abitati del
Crotonese
(2). Esso ci appare come
un complesso fortificato,
edificato alla sommità di una
posizione vantaggiosa, in difesa
della chiesa e degli uomini
raccolti attorno ad essa, dove
spicca la residenza signorile
identificata dalla presenza di
una torre. Dopo la formazione
della terra, la città che
accoglie i coloni accorsi a
coltivare il territorio, e
l’erezione del castrum, la
fortificazione che li difende,
il castello appare distinto
dalle mura di quest’ultimo, in
una chiara posizione eminente ai
margini dell’abitato, a
controllo della città e delle
sue vie d’accesso. Risalta
dunque, come il castello non
costituisca mai un complemento
alle difese della città, ma una
presenza che, in maniera più o
meno marcata, gli si dimostra
sempre contrapposta
(3).
Accanto a questa loro nuova
funzione urbana, comunque, i
castella continueranno a
svolgere il compito che già
assolvevano durante l’età
romana, vigilando sui principali
punti d’attraversamento del
territorio
(4) e mantenendo la loro
caratteristica struttura. Si
trattava di torri a base
quadrata impostate su tre
livelli, di cui l’ultimo
costituito da un terrazzo
protetto da una merlatura. Al
piano terra vi era un ambiente
inaccessibile dall’esterno,
destinato ad ospitare cisterna e
magazzini, dal cui interno si
poteva accedere alla porzione
abitabile o sala della torre,
posta superiormente. Qui si
apriva l’accesso esterno che,
attraverso una postierla,
inserita nelle difese poste a
munire la base della torre,
consentiva di raggiungere la
corte, dove erano gli ambienti
di servizio: cappella,
abitazioni ed i ricoveri per gli
animali. Questo complesso era
difeso da una palizzata e da un
fosso, che munivano il perimetro
esterno sfruttando l’assetto
naturale del luogo.
Kallipóleos nuova sede
vescovile
Posta nell’interno ed
insignita del titolo vescovile,
Kallipóleos – Callipolitanus
compare tra la fine del sec. IX
e gli inizi del X
(5),
in seguito all’abbandono del
tratto Tacina - Squillace
dell’antica via costiera d’età
romana, lungo la nuova strada
che, passando per “Terminum
Grossum”, attraverso l’interno,
giungeva fino al Tirreno
(6).
In particolare, essa controllava
il punto in cui convergevano i
principali assi stradali che
collegavano questo nuovo
percorso con le principali
direttrici d’attraversamento del
Crotonese, ed in ciò risiedeva
la sua importanza che perdurerà
per tutto il medioevo. In questa
fase l’abitato era costituito da
un forte castello posto a
controllo della via, dove, con
il tempo, si andrà sempre
maggiormente evidenziando un
altro elemento caratteristico
dello scenario medievale: la
cattedrale che, con la sua
architettura, arriverà a
sovrastare, in maniera
incombente, qualsiasi altro
edificio cittadino. Ciò si
giustifica alla luce delle
prerogative politiche e
religiose dei vescovi, che si
evidenziano come i signori
feudali dei principali centri
(le civitas/urbs)
(7),
dove i castelli si qualificano
come le loro primitive residenze
(8).
Questa situazione permarrà
ancora nel Cinquecento, quando,
pur con qualche eccezione
(Strongoli), i vescovi, gelosi
della loro autonomia,
manterranno un livello di difesa
autonomo ed indipendente dalle
mura cittadine, realizzando
proprie torri che andranno a far
parte di un unico complesso
comprendente la cattedrale ed il
palazzo vescovile
(9).
Tale situazione appare
cristallizzata a Belcastro, dove
la residenza vescovile si
presenta ancora oggi dominata
dalla torre “Mastra”: un
autonomo e massiccio donjon
(fig. 1)
(10) che, in base alle
strutture superstiti, pare
ascrivibile ad una fase compresa
tra la fine del sec. XI e gli
inizi del XII, quando, a seguito
degli avvenimenti relativi
all’insediamento dei Normanni,
il vescovado bizantino fece
posto al sorgere di
Genecocastren (fig. 2)
(11).
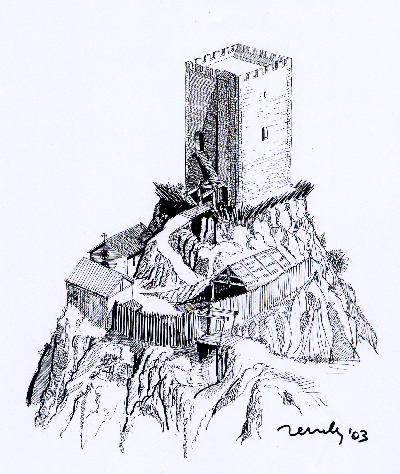
(Fig. 1.
Ricostruzione ideale del
castellum vescovile (fine sec.
XI – inizi sec. XII))
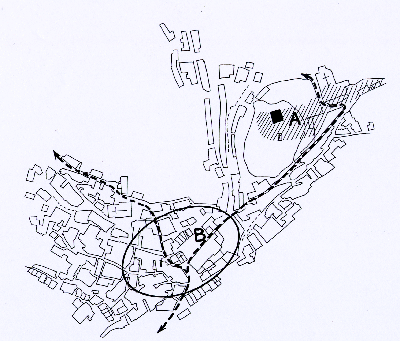
(Fig. 2.
Assetto urbano di Belcastro
(sec. XII – XVI). castellum (A),
castrum (B))
Alla sua base si apriva
l’ingresso, che era ricavato in
un corpo avanzato posto
nell’angolo sud-ovest della
torre, attualmente crollato ma
che, in origine, doveva occupare
tutta l’altezza dell’edificio.
La situazione è evidenziata
dall’area di crollo ed è
testimoniata in altri casi
analoghi (Paternò). Attraverso
questo passaggio ed una ripida
scala esterna che poteva essere
convenientemente rimossa, si
poteva giungere all’ingresso
della torre, posto al primo
piano. Questa torre che occupava
la posizione più elevata, era
circondata da un perimetro
difensivo che muniva la sommità
della rupe, dove sorgevano gli
edifici di servizio alla
residenza del vescovo e della
sua corte e la cattedrale
(12).
Questo perimetro che,
originariamente, doveva seguire
l’andamento naturale del
terreno, fu regolarizzato più
tardi e mantenuto in costante
efficienza, come dimostrano le
diverse strutture difensive che
si rinvengono lungo tutto il suo
percorso. L’importanza
strategica di Belcastro, legata
al controllo della via che
collegava le contee di Catanzaro
e di Crotone, risalta ancora
alla metà del sec. XV, in
occasione degli avvenimenti che
costrinsero i sovrani aragonesi
a scendere personalmente in
Calabria, per sedare le rivolte
del Marchese di Crotone Antonio
Centelles. Durante le operazioni
condotte da re Alfonso,
quest’ultimo si preoccupò subito
di tagliare la strada da cui
potevano provenire aiuti ai
ribelli e, dopo aver assunto il
controllo dei guadi del Neto, si
diresse ad occupare quelli del
Tacina, ponendo l’assedio a
Belcastro il 21.11.1444. Dopo
poco i cittadini si arrendevano
“e gli furono aperte le porte
non possette però espugnar il
castello e la torre detta di
Castellaci”
(13).
Tale quadro appare confermato
durante la successiva discesa di
re Ferdinando che, nel suo piano
d’attacco tendente ad isolare le
città ribelli fedeli al
Marchese, proveniente da
Catanzaro, penetrò nelle terre
di quest’ultimo il 2.10.1459 e
si accampò presso il ponte sul
fiume Crocchio, ponendo
l’assedio a Belcastro
(14).
L’età della riconversione
L’importanza strategica di
Belcastro risalta ancora alla
fine del sec. XV quando, a
seguito della minaccia turca, le
principali piazze del Regno
furono rifortificate. Nel marzo
del 1489 la città fu ispezionata
da Alfonso, duca di Calabria, e
da Antonio Marchesi di
Settingiano
(15),
ed in seguito a questa visita fu
interessata da importanti lavori
d’adeguamento. Questi ultimi,
non apprezzabili nel caso delle
mura cittadine
(16),
si rendono evidenti nel castello
(fig. 3) dove le nuove strutture
paiono integrarsi a quelle
preesistenti. Qui il nucleo
originario, la “torre Mastra”,
fu rinforzata alla base mediante
la realizzazione di un
barbacane, che aveva lo scopo di
aumentare la resistenza della
vecchia torre, fungendo da
ulteriore perimetro difensivo.
Accanto a questi apprestamenti,
il castello fu dotato di un
perimetro esterno con nuove
torri poligonali scarpate
(17),
più adatte ad ospitare le armi
da fuoco. Successivamente, le
necessità di puntamento,
comporteranno la demolizione del
corpo piombato di queste torri,
che sarà sostituito da quello
attualmente visibile per
consentire l’ampliamento del
settore di tiro. Le evidenze
murarie superstiti permettono di
riferire queste ultime strutture
al primo venticinquennio del XVI
secolo, periodo al quale
dovrebbe risalire anche la torre
rotonda, i cui resti si
evidenziano all’estremità sud
del complesso. Si tratta,
comunque, degli ultimi
interventi che sottolineano
l’importanza militare del
castello. Con l’evoluzione della
tecnica bellica legata all’uso
di armi da fuoco più progredite,
il castello di Belcastro, come
altri, perderà le sue funzioni,
riducendosi a residenza dei
feudatari del luogo, che ne
amplieranno gli ambienti interni
in relazione alle loro esigenze
di soggiorno nella città
(18).
In tale ottica si evidenziano le
sopraelevazioni che compaiono
nei tratti superstiti delle mura
perimetrali verso la città.
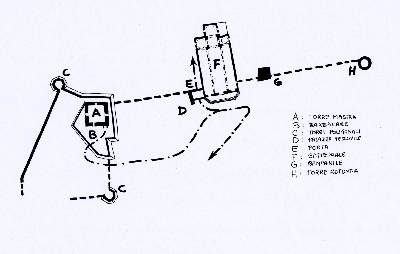
(Fig. 3.
Pianta ricostruttiva del
castello di Belcastro.)
Note
1. Nelle fonti documentarie
i termini latini “castellum” e
“castrum” sono usati senza alcun
riferimento a particolari
tipologie, come del resto
risulta per gli omologhi termini
greci “kastellion” e “kastron”.
L’uso di arx o di oppidum
appaiono invece cultismi legati
all’erudizione della fonte.
Rende P., Il territorio
crotonese in età Romana e
Bizantina, in La Provincia KR n.
10/12 - 2003.
2. Lo stato di oppressione
esercitato dal castello nei
confronti delle popolazioni
urbane c’è testimoniato da
diversi episodi riportati dalle
cronache. Nel 1339, i crotonesi
inferociti espugnano il
castello, poi ripreso dal
capitano della città (Gaggese
R., Roberto d’Angiò e i suoi
tempi, Vol. I, Bemporad, Firenze
1932 p. 332) mentre, nel 1527, i
Mesorachesi dettero alle fiamme
il castello, trucidando il
feudatario con tutta la sua
famiglia (Pesavento A., La città
immaginaria, Crotone nel
Viceregno, 1985 p. 2). Anche i
cittadini di S. Severina erano
“naturalmente” insofferenti ai
gravami imposti dal locale
castello. In tale ottica, dopo
essersi arresi ad Alfonso, essi
si affrettarono a chiedere al
sovrano aragonese “che dicto
castello dirrupi” (Caridi G., Un
privilegio inedito di Alfonso il
Magnanimo alla città di S.
Severina, in Nuovi Annali della
Facoltà di Magistero della
Università di Messina, n.2,
1984, p. 157), mentre nel 1460,
chiesero a re Ferdinando la
grazia che fosse distrutta ed
abbandonata anche la torre di S.
Mauro (Siberene, cit. p.167)
che, evidentemente, esercitava
nei loro confronti qualche tipo
di imposizione. Questo
atteggiamento è evidenziato
anche da alcuni episodi
tramandati dalla cultura
popolare, come nel caso della
leggenda del “re pagano” a
Roccabernarda, o relativamente
al supposto diritto del conte di
Melissa di esercitare nei
confronti della popolazione lo
jus prime noctis.
3. Un esempio è rappresentato
dalla catena di controllo che
caratterizzava il corso del
fiume Neto. Superato il
Castellum de Sclavis, posto
lungo la “via grande” che saliva
in Sila, in prossimità della
confluenza tra i fiumi Ampollino
e Neto, si incontravano: il
castellum di Bellumvedere che
dominava uno dei principali
guadi di quest’ultimo, e quello
di Crepacorium che costituiva
l’ultimo sbarramento per quanti,
provenienti da nord, si
dirigevano verso Crotone.
4. ó Kallipóleos (Belcastro)
compare tra i vescovadi
suffraganei della nuova
metropolia di Santa Severina
riportati nella Diatiposi al
tempo di Leone VI il Filosofo
(886-911), assieme a ó
Akeréntias (Cerenzia), ó tõn
Aesúlon (Isola) e ó Euruáton
(Umbriatico). Successivamente
l’opera fu rimaneggiata. Di
quest’ultima se ne conserva una
redazione che è del tempo di
Alessio Comneno (posteriore al
1084) dove, nella Notitia III, i
vescovadi suffraganei di Agías
Seberínes (Santa Severina)
risultano cinque:
Akeranteías/Acerentinus
(Cerenzia), Palaiokástron/Castri
veteris (Strongoli),
Aisúlon/Aysilorum (Isola),
Euruáton/Euriatensis
(Umbriatico) e
Kallipóleos/Callipolitanus
(Belcastro). Russo F., La
Metropolia di S. Severina, in
Scritti Storici Calabresi
C.A.M., Napoli 1957.
5. In epoca sveva, la
persistenza di alcuni tratti
dell’antico asse stradale di età
romana, è evidenziata dalla
presenza di una “via regia”,
lungo cui si evidenziano i
palatia. Pesavento A., L’abitato
di Alichia, la foresta regia ed
il palazzo Alitio, in cit. n.
19/1998.
6. Come tali i vescovi di
Strongoli e di Isola erano
tenuti a concorrere alle spese
di ristrutturazione del castello
di Crotone. (Reg. Ang. Vol. VI,
1270-71, pp. 109-110).
7. Le caratteristiche di queste
dimore vescovili paiono
strettamente connesse alla
figura del presule medievale
che, oltre a costituire la
principale autorità religiosa,
nell’ambito delle sue
prerogative di signore feudale
della città, riassume anche
funzioni politiche e militari.
Ciò risalta ancora sul finire
del Duecento, quando nel 1284,
durante la guerra del Vespro,
l’esercito di Pietro III
d’Aragona invase la Calabria e
Matteo Fortunato alla testa di
2000 Almugaveri, incendiò il
monastero di S. Giovanni in
Fiore (Bartolomeo di Neocastro,
Istoria Siciliana 1250-1293,
cap. LXXXII, pp. 56-59)
devastando i centri della valle
Neto (Ughelli F., Italia Sacra,
IX, 527). In tale occasione, i
vescovi della zona si fecero
carico di guidare le armi fedeli
alla causa angioina. Ai fratelli
Stefanazia, Ruggero e Lucifero,
rispettivamente arcivescovo di
S. Severina e vescovo di
Umbriatico, si unì il vescovo di
Strongoli (Russo F., La guerra
del Vespro in Calabria nei
documenti vaticani, in A.S.P.N.
1961, pp. 207 sgg.).
8. Ad Isola il vescovo Annibale
Caracciolo rifiuterà di
trasferirsi all’interno della
nuova cinta fortificata
realizzata dal feudatario della
città, e permarrà nella sua
primitiva residenza che, nella
seconda metà del Cinquecento,
sarà rifortificata con una
possente torre di difesa di
fianco alla cattedrale (Visita
del Vescovo G.B. Morra, 1648,
f.25 Arch. Vesc. Crotone; Rel.
Lim. Insulam 1606). Il vescovo
di Strongoli Claudio Vico
(1590-1600) fa completare una
propria torre di difesa presso
il palazzo vescovile che era
stata iniziata dai suoi
predecessori (Rel. Lim.
Strongulen, 1597).
9. Il francesismo donjon
(italiano: dongione) deriva dal
latino dominion, e si riferisce
all’ostentazione del proprio
potere da parte del signore
feudale attraverso la
costruzione della torre.
10.“Geneocastrensem/Genecocastren/Genicocastren”
(= castrum principale), dal 1330
“Bellicastrum” (Rel. Lim.,
1703), sorge conseguentemente
all’insediamento normanno. Le
sue mura, torri e
fortificazioni, esistettero fino
al 1644 quando il grande
terremoto di quell’anno le
distrusse (Rel. Lim., 1758).
11. Durante il sec. XVI tra il
castello e la cattedrale sorgeva
il palazzo vescovile. Pesavento
A., La cattedrale di Belcastro
in La Provincia KR n. 20/22 -
2000.
12. Pesavento A., Alle origini
della provincia di Crotone, in
La Provincia KR, n. 2-7/1996.
13. La città si arrenderà l’otto
ottobre 1459. Fiore G., Della
Calabria Illustrata, Napoli
1691, t. I, 213.
14. G. Filangieri, Documenti per
la storia, le arti e le
industrie delle provincie
napoletane, 1891, vol. I.
15. Vedi nota n. 11.
16. Accanto a quella meglio
conservata, i resti della base
di un’altra torre che appare
dello stesso tipo, si trovano
nell’angolo sud – ovest del
perimetro.
17. In base a queste esigenze,
nel 1549, il feudatario di
Isola, Io. Antonio Ricca,
realizzò la sua residenza
fortificata nelle adiacenze
della nuova città murata mentre,
successivamente, il principe di
Strongoli costruirà la propria
attorno ad una torre medievale
preesistente (la “Maestra”).
Ulteriori esempi di questa
tendenza, sono rappresentati
dalla costruzione del
“Belvedere” all’interno del
castello di S. Severina (1535),
e dalla realizzazione del
palazzo ducale di Caccuri, che
costituisce lo sviluppo in
chiave residenziale del
preesistente castello medievale.
La
città di Belcastro e “La Stella
di San Tommaso”
di Andrea
PESAVENTO
(pubblicato su La Provincia KR
nr. 24-25/2003)
In età
sveva il feudo di Geneocastro
(Genicocastro, Genitocastro)
appartenne ai Fallucca o
Falloch. Alla stessa famiglia
rimarrà per breve tempo anche
dopo la conquista del Regno da
parte degli Angioini, come
risulta dall'atto con cui Carlo
I d'Angiò l'otto luglio 1269
riconosceva a Clemenza o
Clementina Fallucca, per sé ed i
suoi eredi, il dominio feudale
sulla città di Genitocastro.
Clemenza Fallucca, moglie di
Berardo de Czifono o de Tortora,
aveva avuto il feudo come erede
del padre Riccardo e nel 1278/79
ne era ancora in possesso (1).
Dai Fallucca ai De Aquino
Poi passò agli Aquino, in
seguito al matrimonio tra
Fiordelasia Fallucca, sorella di
Clemenza, e Tommaso de Aquino.
Nel 1284 Tomaso de Aquino
risulta già feudatario di
Belcastro con il titolo di
conte. Tommaso de Aquino comandò
l'esercito di Carlo d'Angiò in
Terra di lavoro e partecipò alla
battaglia navale, dove fu fatto
prigioniero assieme al figlio
del re (2). Nel 1292 troviamo
Atenolfo d’Aquino ed alla sua
morte il feudo passò a Tomaso de
Aquino, che nel 1293 ne risulta
in possesso (3). Nel 1330 da
"Gneocastrum" la città mutò il
nome in "Bellicastrum" (4). Nel
1351 risulta conte di Belcastro
un terzo Tomaso o Tommasello de
Aquino che morirà nel 1357 (5).
Seguì Isabella de Aquino come
compare in un documento del 1365
col titolo di contessa di
Belcastro (6).
La Contea nel sec. XV
Alla morte di Isabella
D'Aquino, avvenuta nel 1373,
nello stesso anno pervenne ai
Santoseverino, come risulta
dalla conferma fatta dal papa
Gregorio XI della concessione e
donazione del feudo, fatta dalla
regina Giovanna e dal marito
Ludovico, ad Enrico de
Sanctoseverino ed ai suoi eredi
del comitato di Belcastro (7).
Enrico Sanseverino, uno dei
potenti del regno, era ancora
conte di Belcastro nel 1390 (8).
La contea passò quindi al figlio
Luigi, che fu ribelle a re
Ladislao. Perciò nel 1401 fu
privato del feudo. L'anno dopo
la città venne venduta a Pietro
Paolo da Viterbo, alias Peretto
de Andreis, che ebbe la contea
di Belcastro ed il marchesato di
Crotone. Pietro Paolo da Viterbo
si schierò per il di La Marche.
Nell'estate 1417 le truppe di
Antonuccio dei Camponeschi di
Aquila devastavano le proprietà
di Pietro Paolo da Viterbo,
marchese di Crotone e conte di
Belcastro.
In seguito pervenne ai Ruffo.
Prima Nicolò poi le figlie
Giovannella ed Enrichetta,
moglie quest'ultima di Antonio
Centelles, che fu ribelle al re
Alfonso d'Aragona. Con la
discesa dell’esercito del re
nell’autunno 1444 la città verrà
assediata. Il re, dopo aver
ottenuto il controllo delle
terre e dei passi sul Neto, si
diresse ad occupare quelli sul
Tacina. Il 16 novembre
l'accampamento regio è presso
Rocca Bernarda (9), la quale si
difese tenacemente per alcuni
giorni ma "espugnatone il
castello" le truppe del re, dopo
aver messo a ferro e fuoco
quella terra, si diressero alla
conquista di Belcastro.
Il 21 novembre il regnante è a
Belcastro. In quel giorno
Alfonso concedeva dei privilegi
ai rappresentanti
dell'università di Cropani (10).
Dopo poco i cittadini di
Belcastro si arrendevano " e gli
furo aperte le porte non
possette però espugnar il
castello, e la torre detta di
Castellaci", lasciate delle
truppe di presidio alla città e
per proseguire nell'assedio
(11), il re si diresse su Santa
Severina (12).
Dopo la caduta della città venne
nominato castellano del castello
di Belcastro Galberano de
Barbera (13). In seguito il De
Barbera oltre che castellano
divenne anche governatore e
capitano della città, come
risulta da un ordine di re
Alfonso. Il re il 9 agosto 1449
comandava al tesoriere di
Calabria Gabriele Cardone di
pagare al nobile Galcerando de
Barbera, castellano del castello
e torre di Belcastro e
governatore e capitano della
città ed ai suoi aiutanti il
salario, che a loro spettava,
sia quello arretrato, quanto il
presente ed il futuro (14). Dopo
la morte di re Alfonso divampò
la ribellione in Calabria contro
il re Ferdinando.
Particolarmente cruento fu lo
scontro tra le truppe regie ed i
ribelli nella contea di
Belcastro e nel marchesato di
Crotone, dove erano
particolarmente attivi i seguaci
del marchese di Crotone Antonio
Centelles.
Le operazioni militari si
svolgevano con fasi alterne.
Alfonso d'Avalos, comandante
delle truppe regie, sconfiggeva
il 19 maggio 1459 presso
Belcastro i ribelli e li
costringeva a ripiegare su
Crotone, ma questi scontratisi
con le truppe del tesoriere le
sgominavano. Gli scontri
proseguivano ed il 2 giugno un
esercito composto da contadini
del ducato di Squillace, del
conte di Nicastro e del conte
d'Arena e di altri baroni
subivano una grave sconfitta
presso Maida da Alfonso d'Avalos
che poi però doveva ritirarsi
verso Cosenza.
Frattanto le terre del
Marchesato nell'estate 1459
venivano prese formalmente in
consegna dagli emissari del
principe di Taranto, anche se
nella città di Crotone, già da
tempo in mano ai seguaci del
Centelles, rimaneva ancora nel
castello un presidio regio che
vi rimarrà fino ad agosto. Re
Ferdinando prima di scendere con
l'esercito in Calabria reintegrò
il Centelles nei suoi antichi
feudi. Il marchese ebbe quindi
pieno possesso del suo antico
stato, di cui parte si era già
con la forza impossessato, e che
comprendeva Crotone, Santa
Severina, Belcastro, Catanzaro,
Tropea ed altri luoghi15.
Durante la discesa del re
Ferdinando con un esercito,
Belcastro fu assediata. I
cittadini si arresero l'otto
ottobre dopo aver avuto la
conferma dei privilegi, tra i
quali quello di rimanere in
demanio, ed aver ottenuto alcuni
sgravi fiscali16.
Intanto si arrendevano Santa
Severina, Cirò ed altre città;
resistevano Le Castella e
Crotone. Giunte le tre galee ad
esse si unì un'altra che già si
trovava sui mari di Calabria, ed
insieme posero il blocco e
bombardarono Le Castella, la
quale si arrese dopo che il 14
ottobre il re "in felicibus
castris prope Belcastrum" aveva
accolto le richieste fatte da
Michele Petro a nome di quella
università17.
Il 24 giugno 1462
Ferdinando,accogliendo la
richiesta di perdono e di
sottomissione di Antonio
Centelles e della consorte
Errichetta Ruffo, li reintegrava
nei feudi confiscati a causa
della ribellione, avendo alzato
le loro insegne e le loro armi
in favore degli Angioini e
perdendo per questo i loro beni
che erano stati così donati dal
re: il marchesato di Crotone al
principe di Taranto, le città di
Catanzaro e di Santa Severina e
le terre di Mesoraca, Castella,
Roccabernarda, Policastro,
Taverna, Roccafalluca e Tiriolo
erano state poste in demanio, la
contea di Belcastro, la baronia
di Cropani e le terre di
Zagarise e Gimigliano erano
state date al principe di
Bisignano e a Tommaso Carrafa.
Le terre di Cirò e Melissa, la
baronia di Castelmonardo con le
motte di Montesori e Monterusso
e Polia, le terre di Rosarno e
la baronia di San Lucido con le
motte o terre di San Giovanni e
Montebello, le terre di
Castelvetere e Roccella a
Galeotto Baldaxino assieme ai
casali e alle torri e con la
provvigione di 4000 ducati con
la gabella della seta, Badolato,
Motta di Caccuri e con altre
terre18. Così Antonio Centelles
e la moglie ebbero da re
Ferdinando la città di Crotone
con il titolo e la dignità di
marchese che era detenuta dal
principe di Taranto, la città di
Catanzaro con il titolo e la
dignità di conte, la città di
Santa Severina e le terre di
Mesoraca, Le Castella, Rocca
Bernarda, Policastro, Taverna,
Rocca Fallucca e Tiriolo, terre
in demanio che erano
amministrate da ufficiali del
re, la città di Belcastro con il
titolo e la dignità di conte e
la baronia di Cropani e Zagarise
e la terra di Gimigliano, terre
occupate e detenute dal principe
di Bisignano19 e da Maso
Barrese, le terre di Cirò e
Melissa, la baronia di
Castelmonardo con le motte o
terre di Montesori, Monterusso e
Pollia, la terra di Rosarno, la
baronia di San Lucido, con le
motte o terre di San Giovanni e
Monte Bello, già recuperate e in
possesso del Centelles, e le
terre di Castelvetere e
Roccella, che sono tenute da
Galeotto de Baldexino. A queste
terre che facevano parte dei
vecchi possessi del marchese di
Crotone e di sua moglie il re
aggiunse la baronia di Bianco e
la Torre di Bruzzano con le
motte e castelli di Bovalino,
Pietra Panduta e Crepacore20
Non tutte queste città e terre
ritorneranno subito in potere
del Centelles. Antonio Gazo fu
incaricato di consegnargli
Belcastro, Zagarise e Cropani
che deteneva militarmente il
Barrese; Crotone fu esclusa
dalla consegna e Santa Severina
con il titolo di Principe fu
data solo nel giugno 1464
assieme alla pensione annua di
1000 ducati sulle saline di
Neto. Il Centelles attese alla
riorganizzazione delle sue
proprietà. Nel 1463 diede ad
Antonio Cochi, milanese suo
affine, il casale di San Mauro
de Caraba21, permutò Borrello e
Rosarno ottenendo dal Barrese
Simeri, donò Melissa a Giovanni
de Michele e il feudo di Umbro
Demani ed i mulini della Canusa,
in territorio di Rocca Bernarda,
a Giovanni de Colle.
Il 21 aprile 1465 ormai vedovo
"Antonius de Viginti Milles
alias Centelles ,Princeps Sancte
Severine Marchio Cotroni Dei
(gratia comes) Catanzarii et
Bellicastri" di passaggio per il
monastero di Santa Maria di
Altilia assieme al figlio
primogenito Antonio e alle
figlie convalida al monastero il
tenimento di Neto già concesso
dal conte Petro Ruffo e dal
figlio di costui Giovanni Ruffo
e successivamente confermato
dalla sua defunta "carissima
consorte", la marchesa di
Crotone Enrichetta Ruffo, ed
esenta l'abate Enrico de Moyo
dal censo di tre ducati che
annualmente il monastero doveva
pagare alla sua curia22.
Dopo la fine del Centelles e la
confisca dei suoi feudi,
Belcastro fu concessa a Ferrante
de Guevara, che la tenne dal
1467 fino al 1481 (?) , quindi
nel 1482 a Federico d'Aragona,
figlio di re Ferdinando. Nel
1487 il re Ferdinando I
d'Aragona concedeva la contea di
Belcastro e le terre di
Zagarise, Cropani e Barbaro a
Giovan Giacomo Trivulzio,
compensandolo per valido aiuto
prestato nel reprimere la
Congiura dei Baroni23
Il Trivulzio parteggiò per Carlo
VIII e perciò ne fu privato. Nel
1500 venne data da re Federico a
Costanza d'Avalos (figlia
d'Inigo d'Avalos e sposa di
Federico di Baux). Quindi passò
al nipote Alfonso D'Avalos), che
la alienava nel 1542 a Ferrante
d'Aragona duca di Montalto.
Quindi pervenne a Pietro
d'Aragona e poi al fratello
Antonio, che nel 1574, la
vendeva a Giovanbattista Sersale
di Cosenza, barone di Sellia.24
Il culto di San Tommaso
D’Aquino
Accettando acriticamente le
affermazioni avanzate per la
prima volta da Gabriele Barrio
sul finire del Cinquecento e
riportate, in modo non
convincente, da Girolamo
Marafioti25, Giovan Battista di
Nola Molise alla metà del
Seicento affermava: "Nel
castello di detta città di
Belcastro vi è una pittura
antichissima, dove si vede S.
Tomaso fanciullo, che mostra al
padre il seno aperto pieno di
rose fresche in tempo d'horrido
inverno per il che si vede, e
conosce, che in questo castello
fu fatto quel miracolo, quando
per la gran povertà, e carestia,
che era in quel tempo, S. Tomaso
di nascosto del padre rubbava il
pane, e dava quello a' poveri;
una delle volte il padre, che
vidde il suo seno pieno, gli
domandò, che portava? il
fanciullo per il gran timore, e
riverenza, che osservava al
padre, dubitando non havesse a
disgusto, che lui rubbava il
pane per darlo a poveri,
scusandosi, disse, che portava
rose, e aperto il seno, invece
di pane ritrovaronsi rose, il
quale miracolo fu inditio di
santità"26. La presenza di San
Tommaso d’Aquino, “il Dottore
Angelico”, a Belcastro tuttavia
è storicamente insostenibile.
L’autore della “Summa
Theologica”, figlio di Landolfo
d’Aquino e di Teodora
Caracciolo, figlia del conte di
Teate, visse tra il 1225/1226,
anno della sua nascita a
Roccasecca, ed il 1274, anno
della sua morte a Fossanova.
Durante tale periodo è
documentato che il feudo di
Genitocastro appartenne ai
Falloch o Falluca. La stessa
presenza del santo non verrà
richiamata in alcuna relazione
dei numerosi vescovi di
Belcastro fino all’arrivo del
vescovo Giovanni Emblaviti
(1688- 1722). Sarà l’Emblaviti
che sul finire del Seicento,
utilizzando allo scopo anche
l’iconografia del santo, darà
impulso al culto popolare di San
Tommaso d’Aquino e nuovo vigore
alla falsa credenza, inventata
di sana pianta dal Barrio e poi
ripresa da altri scrittori, tra
i quali Girolamo Marafioti,
Giovanni Lorenzo Anania, Elia de
Amato, Saverio Zavarroni,
Francesco Grano, Lucio d’Orso
ecc.. Ma veniamo al vescovo
Emblaviti, il quale nella
relazione, datata nove novembre
1692, non solo afferma che il
santo era nato a Belcastro, ma
evidentemente, traendo spunto
dal fatto, che spesso il santo è
rappresentato con un sole o una
piccola stella, che emana raggi
di luce dal suo petto, per
essere più convincente, riporta
la descrizione del prodigio, che
secondo lui si verificava il 28
gennaio di ogni anno a
Belcastro, giorno della festa
del santo. Il prodigio
consisteva nell’apparizione di
una stella fissa, posta al
centro di una grande croce
propria dei cavalieri
gerosolimitani, ma di lunghezza
maggiore. Secondo il vescovo,
che ci offre anche un disegno
dettagliato di questa
apparizione, tale evento
miracoloso si verificava sopra
il luogo, dove la tradizione e
la storia indicavano che era
nato il santo, e così descriveva
l’avvenimento: “....Bellicastrum
itaque antiqua et pervetusta est
Civitas a Philottete fundata,
quae in medio celebre Castrum
habet in cuius ruinis semper
extitit et ad praesens usque
perseverat cappella et oratorium
in honorem Angelici Doctoris
Divi Thomae de Aquino in loco in
quo traditio, et historia ferunt
ipsum sanctum doctorem habuisse
natalia. A primis insuper
vesperis usque ad occasum
dieifesti ipsius apparet in
eodem loco quaedam stella etiam
in meridie visibilis......nam
post missae celebrationem ipsam
prospexi stellam, quae est fixa
super signo magnae crucis
eiusdem figurae cuius est crux
quam deferunt Equites
Hierosolimitani sed maxime
lungitudinis"27. L’Emblaviti
proseguirà anche successivamente
nel suo intento, teso ad ubicare
la nascita del santo nel
castello di Belcastro,
aggiungendo come avvenuti in
quel luogo anche alcuni episodi
che fanno parte della vita
miracolosa del santo, come
quello della trasformazione del
pane in rose. "...Magnum
circuitum Urbis denotant ossa
arida, et congeries lapidum,
dirutique aedificiis moles cum
insigni positura Castri
devastati ictu, et vi Arietis à
baronibus sub spe thesauri,
itaquod ibi tantum remansit
ecclesia pervetusta sancti
Thomae Aquinatis, qui in hoc
castro clara habuit natalia, et
est verisimile, nam in antiqua
scala adsunt arma Domus
Caraccioli mixta, et in saxo
incisi flores in quos asserunt
egregium tunc juvenem
convertisse eleaemosinas quas
adiacenti carceri, qui adhuc
extat afferebat e cospectu arcis
in supremo civitatis, vasta
adest turris teres immense
altitudinis ad huc
inhabitabilis.... In arce
Bellicastri existit pervetusta
ecclesia S. Thomae Aquinatis in
loco Natalium ipsius Angelici
Doctoris, quae substentatur
eleaemosinis fidelium"28. Ed
ancora: “Vi è dentro il castello
di Belcastro una piccola ma
antica chiesa dove tramandano
che ebbe i natali e fece il
miracolo delle rose il Santo
Dottore, nella quale si celebra
dai domenicani la messa nei
giorni festivi29.
L’incremento del culto di San
Tommaso d’Aquino, che diviene
protettore della città,
proseguirà anche dopo la morte
dell’Emblaviti. Il successore
Michelangelo Gentile (1722-
1729) il 22 luglio 1724 chiedeva
al papa Benedetto XIII qualche
aiuto per la chiesa di
Belcastro; luogo importante in
quanto vi nacque S. Tomaso
d’Aquino, “stella risplendente
dell’Ill.ma Religione
Domenicana”30 ed affermava che
vi è un altare dedicato
all’Angelico Dottore dentro il
castello in memoria
dell’antichissimo dominio, che
la nobilissima famiglia de
Aquino possedeva sopra
Belcastro, mentre viveva il
Santo Dottore31.
Temi ripresi ed ampliati in
seguito dal vescovo Giovan
Battista Capuano (1729 -1752) il
quale afferma che a Belcastro vi
era una piccola chiesa dedicata
a San Tommaso D’Aquino,
protettore della città, posta al
centro dell’antico castello. Gli
abitanti di Belcastro dicono che
il santo nacque in questa città,
quando suo padre conte d’Aquino
possedeva lo stato di Belcastro.
Il vescovo inoltre afferma che
il culto verso il santo andava
crescendo giorno dopo giorno.
“Gli abitanti di Belcastro e dei
paesi vicini nutrono una grande
devozione verso il Santo
Dottore, che durante il periodo
della mia permanenza ha avuto un
notevole incremento. Nel giorno
della sua festa, quando appare
la prodigiosa stella sopra la
chiesa, vi è un grandissimo
concorso di gente, che viene
anche dai paesi vicini per
assolvere i voti. Per
amministrare bene tutte le
elemosine e le donazioni ho
nominato un procuratore, il
quale mi rende conto ogni anno.
Vi è la statua del Santo
Protettore ben decorata e
mantenuta, che prima era
venerata nella chiesa della SS.
Annunciazione. Curai farla
trasportare con la debita
decenza e venerazione dentro la
chiesa cattedrale. Qui la feci
collocare dentro un elegante
armadio, dal quale spesso viene
tolta per essere esposta alla
devozione popolare e per
portarla processionalmente,
specialmente quando si deve
venire incontro alle urgenti
necessità della popolazione32.
Il culto verso il santo
proseguirà durante il lungo
vescovato di Tommaso Fabiani
(1755 -1778), il quale ribadirà
tutte le affermazioni già fatte
dall’Emblaviti e dai vescovi
successivi, contrastando coloro
che le mettevano in dubbio.
“Unum ei superest (nec minimum
est) quod nec temporis
audacitas, nec humanarum rerum
vicissitudines ipsi adimere
potuere: esse Patriam, et frui
patrocinio Angelici Doctoris
Divi Thomae Aquinatis, qui hic
ex Landulpho, et Theodora tunc
Bellicastri comitibus in lucem
aeditus est, ut inter plurimos
tenet eminentissimus Sirletus,
Barrius, Joannes Laurentius
Anania, Elias de Amato, et
novissimè disertè probavit
Xaverius Zavarroni, seu potius
Antonius Episcopus Tricaricen
eius frater in responsione ad
dissertationem Francisci
Pratilli canonici Capuani de
patria et familia divi Thomae
Aquinatis, aedita anno 1751;
idemque comprobare nn deest ipse
sanctus cum apparitione stellae,
quae à primis vesperis usque ad
occasum solis diei festi
eiusdem, super castro ubi
creditur ortus fuisse, et
quandoque per totam octavam,
etiam in meridie visibiliter
apparet, existente tamen coelo
sereno, sicuti propriis oculis
egoipse vidi. Monumentum tamen
huius veritatis posteris
demandavit JOannes b.m.
Emblaviti, episcopus huius
civitatis in fide authentica,
sua obsignata manu propria sub
die nona mensis Novembris 1692
cum figura ipsius stellae, cuius
forma hic describitur"......
Ecclesia divo Thomae Aquinati
nostro inclyto Protectori extat
inaugurata, quae parva sua
extensione, fuit posita in
centro vetustissimae Arcis
bellicae, in qua, ut ex
traditione non contemnenda
praecitatus Divus natus
est........ Ad haec, quotannis
recurrentibus vesperis eius
festivi diei, int. castrum
pralaudatum et cathedralem
ecclesiam splendidiore
hilarioreq. lumine ima fulget
stella quaedam (Divi Thomae
vulgus adpellat) ex hora diei
nona, per totos octo solidos
dies, coelo praesertim sudo,
quaeq. nedum civibus sese
praebet conspicuam, sed etiam
exteris, undiq. propterea, sive
prodigii magnitudine, sive erga
Divum hominem reverentia moti,
concurrentibus. Porro ab aevo,
cuius memoria non extat, scimus,
Divum Thomam in praecipuum huius
Diocesios patronum fuisse
adlectum”33.
Il culto
Sempre proseguendo su questa
via, per sostenere la nascita a
Belcastro ed incrementarne il
culto, verrà “fabbricata” una
vecchia pergamena con una falsa
fede di battesimo e saranno
scritti inni di lode. Ancora
all’inizio del Novecento Antonio
Puja, fratello dell’arcivescovo
di Santa Severina, affermava che
occorreva proseguire nella
ricerca storica, in quanto non
vi era la certezza della nascita
di San Tommaso d’Aquino a
Belcastro, anche perché gli atti
portati a favore non reggevano,
“dinanzi alla critica, che possa
vincere gli avversari, e
assicurare a noi l’alto onore”.
Il prelato non negava la gloria
di tale nascita a Belcastro anzi
aggiungeva che, pur mancando
documenti storici validi, una
delle prove a favore poteva
essere la tradizione. La città
di Belcastro “da secoli ha
trasformata in cappella la
stanza del castello dove dicesi
nato S. Tommaso: Belcastro ha
trasmesso da generazione in
generazione la memoria di quel
nascimento e, insieme il culto
al Santo Dottore, come culto al
suo più gran figlio: Belcastro
ricorda anche oggi la stella
apparsa nel suo cielo, il giorno
della nascita dell’Angelo delle
scuole..”34.
Note
1. Reg. Ang. I, 294, 300
sgg.
2. " Si ha notizia che
Fiordelasia, moglie di Tomaso
padre di Adenolfo primo signore
di Castiglione e di Filippa,
moglie di Tomaso conte di
Belcastro che espone al re, come
essendo stato Tomaso con Carlo,
principe di Salerno, fatto
prigioniero nella battaglia
navale e sui beni in vigore di
ordini regi per il secreto e
mastro portolano del sale di
terra di Lavoro e contado di
Molise, essendoci la
sospensione, chiede
sostentamento e alimenti. Il re
ordina che salva la porzione di
Adenolfo, fratello minore di
Tomaso, gli si paghino 40 once
d'oro sui proventi della terra
di Tomaso in ciascun anno
dissequestrando i beni del
marito (28/8/1284, Reg. Ang.
XXVII, 467 -468)
3. Lenormant F., La Magna Grecia
cit., II, 240; Pellicano
Castagna M., La storia dei feudi
cit., I, 175.
4. Rel. Lim. Bellicastren., 1703
5. Russo F., Regesto, I, 7184
6. Russo F., Regesto, II, 7774.
7. Russo F., Regesto, II, 8022.
8. Ladislao, figlio di Carlo III
e di Margherita di Durazzo,
veniva incoronato il 23 maggio
1390 re di Sicilia dal cardinale
Angelo Acciaiuoli, legato del
nuovo papa Bonifacio IX che
intendeva così averne l'appoggio
contro il papa scismatico
Clemente VII ed i suoi alleati,
il re Carlo VI ed il pretendente
angioino al regno napoletano,
Luigi II d'Angiò. Il nuovo re
per i servizi prestati al padre
e alla madre e per tenerlo
alleato, il 18 ottobre 1390 creò
Nicolò Ruffo marchese di
Crotone, dando l'incarico
dell'investitura ad Enrico
Sanseverino, conte di Belcastro,
Carlo Ruffo di Montalto e di
Corigliano, Giordano Arena,
signore della baronia di Arena,
e a Benedetto Acciaiuoli, tutti
membri del consiglio di
reggenza, Minieri Riccio C.,
Notizie storiche tratte da 62
registri angioini dell'archivio
di stato di Napoli, Napoli 1877,
p. .99.
9. Il re quel giorno approva i
capitoli presentatogli dai
rappresentanti dell'università
di Lucera, Mazzoleni J., Fonti
per la storia dell'epoca
aragonese nell'archivio di stato
di Napoli, ASPN a. 1954, p. 352.
10. A Belcastro il 21.11.1444 il
re concesse ai rappresentanti
dell'università di Cropani di
rimanere in demanio, che la
città fosse franca per 10 anni
da qualsiasi tassa, che i suoi
cittadini potessero pascolare
franchi nei territori di Taverna
e di Belcastro che i beni
requisiti fossero restituiti,
che alla chiesa collegiata di
Santa Maria fossero date le
terre di Connino, che
all'abbazia di S. Maria di
Acquaviva fossero confermate
tutti i privilegi ecc., Fiore
G., I, 213.
11. D'Amato V., Memorie
historiche dell'illustrissima
famosissima e fedelissima città
di Catanzaro, Napoli 1670, p.
98.
12. Costanzo A., Istoria del
Regno di Napoli, Milano 1805,
III, p. 132; Pontieri E., La
Calabria cit., p. 132.
13. Falanga M., Il manoscritto
di Como, in Rivista Storica
Calabrese, n. 1/2 - 1993, p. 245
14. Fonti Arag., I, 76.
15. Costanzo A., Istoria del
Regno cit., III, 190-191; Dito
O., La storia cit., pp.218 sgg.
16. Fiore G., Della Calabria
cit., I, 213.
17. Tra i capitoli approvati vi
era la conferma al vescovo di
Isola degli antichi privilegi,
Processo Grosso, ff. 415-416,
AVC.
18. Pontieri E., La Calabria
cit.,284-285.
19. Il conte di Sanseverino era
stato inviato dal Re stesso a
trattare col Duca di S. Marco, e
questi volle ed ottenne
promessa, che avrebbe avuto
vigore l'albarano già fatto tra
lui ed il re Alfonso, col quale
gli si accordava il governo
della contea di Belcastro e
della baronia de li Cropani, e
che si sarebbe fatto grazia a
più che 500 fuorusciti de'
casali di Cosenza ( Memoriale
presentato alla M. del Re per lo
nobile Antonello da Prignano per
nome et parte de lo Ec. conte di
Sanseverino e che per la dicta
M.a fu decretato come infine de
ciascuno dei capitoli se
contiene. In Regio castro
Civitatis Capue die XXIII
decembris 1459)", Giampietro D.,
Un registro aragonese della
Biblioteca Nazionale di Parigi,
ASPN, 1884, p. 643)
20. Processo Grosso... Processo
Grosso .. ff. 74-96; De Leo P.,
I patti tra la corona d'Aragona
e il Centelles, A.S.C.L., LX
(1993), pp. 93 sgg.
21. Fiore G., Della Calabria
cit., I, 221.
22. Il privilegio fu concesso
"in dicto monasterio die 21
mensis Aprilis XIII Ind. 1465,
Privilegi della Badia di Altilia
cit. ff.11 sgg.
23. Mazzoleni J, Regesto della
Cancelleria Aragonese cit. , p.
161.
24. Pellicano Castagna M., La
storia dei feudi cit., Vol. I,
pp. 173 sgg.
25. Marafioti G., Croniche et
antichità di Calabria, Padova
1601, pp. 215- 216.
26. Nola Molise G.B. Cronica
cit., p. 85
27. Rel. Lim. Bellicastren.,
1692.
28. Rel. Lim. Bellicastren.,
1699.
29. "In Arce Civitatis adest
ecc.a angelici doctoris in loco
ut fertur suae nativitatis
pervetusta cum signo rosarum in
memoriam miraculi ab ipso, ut
dicitur, patrati in ianua
carceris in lapide sculpti",
Rel. Lim. Bellicastren., 1711.
30. Vesc. Vol. 141, f. 174 -175,
ASV.
31. Rel. Lim. Bellicastren.,
1727.
32. Rel. Lim. Bellicastren.,
1735.
33. Rel. Lim. Bellicastren.,
1758.
34. Documenti di Archivi,
Siberene pp. 477 sgg.
La
cattedrale di Belcastro
di Andrea
PESAVENTO
(pubblicato su La Provincia KR
nr. 20-22/2000)
Secondo
alcuni storici “Kallipoleos”,
una delle primitive diocesi
della metropolia di Santa
Severina, altro non sarebbe che
Belcastro1.
Da Genitocastro a Belcastro
La città, così detta durante
il periodo bizantino, avrebbe
poi mutato in Genitocastro, come
appare in numerosi documenti di
età normanno- sveva2, quando era
feudo dei Falloch.
Nella prima età angioina, poco
prima della metà del Trecento,
essa assunse l’attuale
denominazione3. Secondo alcune
testimonianze la città nel
Medioevo era abitata da tre
popolazioni : ebrei, greci e
latini4.
Nelle collette per la Santa Sede
dell’inizio del Trecento oltre
al vescovo compaiono anche le
quattro dignità, cioè il decano,
l’arcidiacono, il cantore ed il
tesoriere5.
Le ritroviamo ancora alla metà
del Cinquecento quando la cura
delle anime risiedeva nel
capitolo6. In seguito a causa
della diminuzione della
popolazione, essa fu assegnata
al solo arciprete, che divenne
il parroco di tutta la città7,
ed assieme al penitenziere portò
a sei le dignità della chiesa di
Belcastro8, e tali erano ancora
alla fine del Seicento9.
La cattedrale intitolata
all’arcangelo San Michele, la
cui immagine era impressa nel
sigillo del capitolo, era
l’unica parrocchia della città e
conservava tutti i sacramenti.
Secondo una tradizione locale
riportata dal Fiore, essa era
stata fondata nell’Undicesimo
secolo e dotata da un tale
Angiolo Carbone, patrizio della
città, il quale, non avendo
eredi, la istituì e le lasciò in
eredità tutto ciò che aveva e
cioè “Palaggi, vigne, tenute di
terre, e singolarmente il feudo
detto Spertuso”10.
Al tempo del vescovo Giovan
Antonio di Paola (1577 – 1591)
il papa Gregorio XIII concesse
nel 1583 un privilegio ad un suo
altare, come si rileva da
iscrizione11.
Nel 1592, al tempo del vescovo
Orazio Schipani (1591- 1596),
annoverava oltre alle dignità
otto canonici e 25 preti12 ma a
causa di una pestilenza il
vescovo Alessandro Papatodero
nel 1597 vi troverà solo 6
canonici e 15 preti13.
La diocesi compresa tra i fiumi
Crocchio e Tacina giungeva fino
alla riva del mare e confinava
con le diocesi di Catanzaro,
Isola e Santa Severina. Essa nel
Seicento comprendeva oltre alla
città di Belcastro anche i due
villaggi di Andali o Villa
Aragona, abitato di Albanesi, e
di Sant’Angelo o Cuturelle.
Belcastro, città posta su un
colle a circa tre miglia dal
mare, nei primi decenni del
Cinquecento era ancora fiorente
di cittadini e di messi ma in
pochi anni arrivò la decadenza.
Nel 1542 la cattedrale risultava
completamente distrutta
(“penitus collapsa”) tanto che
il papa Paolo III il 12
settembre di quell’anno
concedeva ai visitatori e a
coloro che avrebbero contribuito
a risollevarla nella festa di S.
Michele l’indulgenza per un
giorno14. Ma le condizioni della
città peggiorarono ed a causa
dell’insalubrità dell’aria molti
cittadini la abbandonarono15. Lo
spopolamento e la malaria fecero
impoverire la mensa vescovile,
lasciata in abbandono; infatti
tra il 1595 ed il 1615 ben sette
vescovi si susseguirono. La
precarietà del potere vescovile
favorì l’usurpazione di alcuni
terreni della chiesa16 e la
povertà si ripercosse sulla
cattedrale. Di mediocre
struttura, essa all’inizio del
Seicento era cadente e
necessitava di grandi
restauri17. Anticamente era
situata in mezzo alla città, ma
poiché gran parte dell’abitato
era stato abbandonato, ora se ne
trovava del tutto al di fuori.
Vi si festeggiava solennemente
due volte all’anno : l’otto
maggio ed il 29 settembre. Aveva
fonte battesimale, campanile,
con due campane, alcune reliquie
di santi e la sacrestia ma, sia
per l’incuria dei vescovi che
per la diminuzione delle
entrate, mancava di paramenti
adatti al culto e quelli che
c’erano erano modesti18. Il
vescovo Girolamo Ricciulli ,
rivendicò i beni della chiesa19
e restaurò dapprima la
cattedrale nelle pareti, nel
tetto e nel pavimento. Ne riparò
le scale di accesso, fece rifare
il bastone pastorale, il piviale
e due pianete di seta e fornì di
suppellettili di legno
l’altare20. In seguito rifece la
porta maggiore in maniera
artistica, riparò il soffitto
ligneo, quasi divelto dalla
forza del vento e acquistò e
preparò il materiale sia per
ricostruire la sacristia in
forma più ampia ed in un luogo
migliore sia per rifare l’altare
maggiore.
Nella chiesa vi erano i cinque
canonicati della SS.
Annunciazione, di San Pietro, di
San Pietro e Sofia, di S.
Giacomo e Lucia e di San Marco.
Il vescovo curò anche di
rinnovare ed indorare il
crocifisso di legno21.
Morto Girolamo Ricciulli seguì
Antonio Ricciulli (1626 – 1629)
ed a questo Filippo Crino (1629
–1631).
Se la chiesa era stata risanata,
mancava ancora di organo e di
molti e vari arredi e
suppellettili e quelli che vi
erano vecchi. Così nel 1632 il
sindaco dei nobili della città
collocò una nuova sede per il
magistrato cittadino22 ed il
papa Urbano VIII l’anno dopo
diede la possibilità al nuovo
vescovo Bartolomeo Giptio di
impiegare i proventi delle pene
della sua curia per l’acquisto
delle cose sacre necessarie23.
L’edificio tuttavia continuò ad
essere trascurato soprattutto
per l’assenteismo del presule a
causa dell’inospitalità del
luogo24. Infatti esso era
esposto d’inverno ai rigidi
venti ed all’umido e d’estate
all’eccessivo calore e all’aria
malsana. Inoltre la cattedrale
era in un luogo isolato,
circondata da rupi sassose e da
case distrutte ed abbandonate25.
Proseguivano le usurpazioni
delle proprietà e delle
prerogative della chiesa,
facilitate dall’assenza del
vescovo, il quale a volte
tentava la reintegra della
mensa. Al centro delle contese
fu il diritto di esigere le
decime a ragione di un tomolo di
frumento su ogni giogo di buoi,
anche di estranei, da pagarsi
sia sui terreni feudali che
burgensatici della diocesi26. Le
liti si inasprirono tanto che il
vescovo ricorse all’arma della
scomunica27. Scossa dal
terremoto del 1638, all’inizio
del vescovato del messinese
Francesco di Napoli (1639 -
1651) era così cadente che, per
ripristinarla, non sarebbero
bastate le entrate della mensa
vescovile di più anni28. Essa
aveva l’altare maggiore rivolto
ad oriente e la facciata, dove
si apriva la porta maggiore,
guardava ad occidente. Non era
molto capiente ma sufficiente
per la popolazione. Divisa in
tre navate ; la mediana, la più
spaziosa, era posta tra le due
ali laterali più ristrette, che
la completavano per tutto
l’ambito. Nella parte superiore
della navata centrale il vescovo
fece erigere un nuovo altare
maggiore, dedicato al patrono
San Michele Argangelo, di forma
più grande del precedente (lungo
e largo palmi 11, alto palmi 4 e
½ con lunghezza del piano palmi
3 ½) e costruito in maniera
artistica e dorato. Ai lati vi
eresse delle colonne
“cementizie” che fece dipingere
con varie figure. Nella parte
superiore, a destra, c’era la
cappella dove era conservato in
una custodia dorata lo SS.mo
Sacramento dell’Eucarestia, che
godeva di grandissima
venerazione popolare. In essa le
candele erano sempre accese.
Sempre nella parte superiore,
però a sinistra, c’era la
sacristia molto ristretta. Essa
era in grandissimo abbandono e
fu rifornita di alcune
suppellettili sacre, tra le
quali tre pianette, mentre
quelle che c’erano furono
riparate o rifatte. Vi trovò
anche quattro calici con patene
dorate, mentre i paramenti
pontificali dovevano essere
rifatti perché completamente
consumati. Dietro l’altare
maggiore, che era privilegiato
per indulto di papa Gregorio
XIII vi era il coro molto
piccolo e buio nel quale nei
giorni festivi prendevano posto
le dignità ed i canonici. Vi era
lo stallo vescovile, in mezzo a
quello dei canonici. All’arrivo
del vescovo esso era in più
punti cadente e mostrava un
aspetto modesto, ma ben presto
fu trasformato in una forma più
gradevole, aggiungendovi varie
opere plastiche di mirabile
candore ed ornandolo con statue
ed insegne. Per rendere ogni
cosa più chiara e bella, vi
aveva fatto aprire in alto anche
una magnifica ed ampia finestra.
Esso era decorato con varie
sculture ed era adatto perché il
vescovo potesse svolgere i
divini uffici. Davanti
all’altare maggiore c’era il
sedile vescovile che ornò.
Costruito in legno, lo fece
spostare dal corno dell’Epistola
e quello dell’Evangelo e costruì
vicino ad esso un nuovo pulpito,
che fece decorare con cornici ed
ornamenti eleganti. Il vecchio
infatti era così malmesso che
non era decoroso da esso
annunciare ai fedeli la parola
di Dio. Il soffitto della chiesa
e due pareti che per la
vecchiaia ed i terremoti
minacciavano rovina, furono
riparate. Per dare maggiore luce
all’edificio, fece aumentare il
numero delle finestre,
aggiungendone due in alto nei
muri laterali. La cappella dello
SS.mo Sacramento che era eretta
a destra dell’altare maggiore,
internamente era trascurata ed
la cupola di fabbrica, pur
essendo ammirevole, era stata
consegnata completamente rustica
e mostrava le sue pietre
tagliate lucide e semplici. Con
le elemosine dei devoti, con le
entrate della cappella e col suo
denaro il vescovo aveva curato
di rivestirla di opere plastiche
da cima a fondo. Egli vi aveva
messo varie statue, insegne e
sculture, così era divenuta più
bella ed importante, tale da
indurre nel popolo una maggiore
devozione e considerazione.
Inoltre l’aveva arricchita di
due dipinti di grandissima
stima, che aveva fatto appendere
alle pareti. Dentro la
cattedrale vi erano erette
quattro cappelle che erano di
iuspatronato di particolari, con
doti molto esigue, eccetto la
cappella del Sangue di Cristo
della famiglia dei Ballatore.
Nel lato destro presso la porta
maggiore vi era la fonte
battesimale, fornita di ogni
cosa necessaria. Vi si trovavano
inoltre varie sepolture, sia
davanti alla cappella dello SS.
Mo Sacramento che all’altare
maggiore. La sacristia che era
in grandissimo abbandono fu
rifornita di alcune
suppellettili sacre, tra le
quali tre pianette, mentre
quelle che c’erano furono
riparate o rifatte. In essa
trovò quattro calici con patene
dorate, mentre i paramenti
pontificali dovevano essere
rifatti perché completamente
consumati. La chiesa mancava di
organo ma completava la
struttura il campanile sul lato
sinistro con tre campane, una
delle quali, la maggiore, era
spezzata. Al suo arrivo il
vescovo Napoli aveva trovato due
croci di cui una d’argento aveva
l’immagine del Crocifisso e
l’altra quella dell’Arcangelo
San Michele. Il vescovo aggiunse
un nuovo sacrestano ai quattro
diaconi selvatici in modo da
conservare la chiesa sempre
pulita e funzionante29.
Il nuovo vescovo Carlo Sgombrino
(1652 - 1672) entrò subito in
lite con il vescovo di Isola
Giovan Francesco Ferrari,
accusandolo di esercitare il
potere temporale sulla città,
violando la giurisdizione e
l’immunità ecclesiastica30. Di
modica grandezza ma adeguata
alla popolazione ha campanile,
campane e cimitero. Nella
sacrestia conserva un
reliquiario di ebano, costruito
con grande maestria, con le
reliquie degli SS. Aureliano,
Venanzio e Pio Martire31. Se a
parere del vescovo Sgombrino
l’edificio non aveva bisogno di
alcun riparo, la situazione
prospettata dal nuovo vescovo
Carlo Gargano (1672 -1683) non
era delle più rosee.
La città, feudo del duca
Francesco Sersale, risultava
provata dall’epidemia che
nell’anno 1672 l’aveva duramente
colpita, causando la morte di
circa 300 persone e privandola
così in pochissimo tempo di
quasi un terzo dei suoi
abitanti.. Il palazzo vescovile,
vicino alla cattedrale, era in
completo abbandono in quanto da
circa venti anni nessun vescovo
l’aveva abitato e la cattedrale
era talmente rovinata e così
carente di suppellettili che il
vescovo aveva dovuto subito
mettersi all’opera e per
renderla decente aveva dovuto
impiegare anche del suo32.
Dopo i brevi vescovati di
Benedetto Bartolo (1684 - 1686)
e di Alfonso Petrucci (1686
-1687), i quali all’atto della
consacrazione si erano impegnati
a riparare la cattedrale ed il
palazzo vescovile, a costituire
la prebenda teologale e la
penitenzieria ed ad erigere il
Monte di Pietà33, seguì Giovanni
Emblaviti il quale dovette in
primo luogo trovare rimedio alla
cattedrale quasi completamente
distrutta dal terremoto del 1689
ed a rifare il palazzo vescovile
rimasto in abbandono ed
inabitato per quasi quaranta
anni. Egli fece aprire una nuova
via piana, in modo da avvicinare
la città alla cattedrale,
facendo scavare il sassoso monte
che le separava. Poiché la
cattedrale era circondata da
solide rupi, le fece togliere in
parte per erigervi una sacrestia
più ampia. La spesa era grande e
le sue entrate non bastavano,
perciò vi impegnò parte del
denaro concesso da papa
Innocenzo XI (1676 -1689) alla
città e che doveva servire a
riparare i danni del
terremoto34. Fu perciò accusato
da molti di non avere
distribuito il denaro ai
terremotati ma di averselo
trattenuto ed usato a suo pro35.
Poiché la città pativa per la
vicinanza di stagni, la risanò
facendo svuotare un lago
profondo 16 palmi e più di cento
lungo.
Alla fine del Seicento la
cattedrale era stata restaurata
. Costruita presso l’antica
rocca, aveva sette altari :
altare maggiore dedicato a San
Michele Arcangelo, S. Giuseppe e
l’antica icona di S. Maria delle
Grazie detta delli Greci, altare
SS. Sacramento privilegiato, S.
Antonio da Paola di iuspatronato
della famiglia Gargano, SS.
Sangue di Cristo di iuspatronato
della famiglia Ballatore, il
Gloriosissimo Crocifisso di
iuspatronato vescovile nel quale
c’era l’onere di una messa
settimanale fondato dal vescovo
Napoli. C’era poi l’altare dei
Santi martiri Vito e Modesto e
quindi l’altare di iuspatronato
della famiglia Raimondo che
conservava diverse reliquie di
martiri36.
Il vescovo Emblaviti afferma di
continuo nelle sue ultime
relazioni di aver portato a
compimento il palazzo vescovile
e la cattedrale, dal pavimento
al tetto, rendendo il primo
abitabile e la seconda completa,
con nuove cappelle e fornita di
sacre suppellettili37. Egli
inoltre aveva costruito una
conveniente sacrestia, rifatto
il grande campanile che stava
cadendo, munendolo di campane,
aveva avvicinato la chiesa alla
città, rompendo il monte ed
aprendo una via piana e breve,
in modo che i cittadini
facilmente potessero frequentare
la chiesa38.
Dopo quasi 35 anni di vescovato
gli succedette Michele Gentile
(1722- 1729 ?), il quale
descrive una situazione che non
lascia dubbi sull’operato del
vescovo Emblaviti.
La cattedrale che ci descrive è
sia formalmente che
materialmente “quassata”, senza
trono, senza coro, senza sacre
suppellettili, con i
confessionali a pezzi e mancante
di qualsiasi oggetto necessario
al culto. Il palazzo vescovile è
“diruto“ ed inabitabile. Il
predecessore non vi ha speso un
soldo ed per tanti anni
indecorosamente ha abitato in
una piccola parte. La cattedrale
è “diruta” ed in abbandono, è
mancante di suppellettili e con
il campanile pericolante39.
Il vescovo tentò subito di
ottenere il permesso per
trasferirsi altrove “al fine di
potersi curare” e “perché i
Calabresi devono essere
governati da Calabresi”40. Poi
entrò in conflitto con il barone
del luogo, Alfonso Poerio, che
scomunicò41, con il capitolo
della cattedrale e con i
regolari. La situazione
precipitò tanto che la chiesa di
Belcastro fu oggetto di una
lunga visita da parte
dell’inviato papale Giuseppe
Perrimezzi, vescovo di Oppido42,
che tentò di conciliare gli
animi ed indagò sulla reale
entità delle rendite della mensa
vescovile43. Specialmente la
sacrestia aveva bisogno di
grandi restauri. Il Gentile con
lo spoglio del suo predecessore,
completò il restauro del
campanile che minacciava rovina,
riparò i muri di tutta la
chiesa, costruì un nuovo coro,
l’altare maggiore e la sede
pontificale. Fornì inoltre un
nuovo bacolo d’argento con due
calici e patene ugualmente
d’argento, preziose dalmatiche e
suppellettili, messali e libri.
Rimanevano ancora circa 440
ducati e questa somma fu
impiegata nella riparazione
della chiesa. Intervenne infatti
il visitatore apostolico, il
quale curò stipulare un
contratto con mastri muratori ed
altri artefici, i quali si
obbligarono al restauro
integrale dell’edificio per la
somma di 550 ducati44. Il
vescovo se ne morì “non senza
sospetto di veleno”, lasciando
appena 460 ducati45. I lavori
dopo poco si fermarono, anche se
il capitolo della cattedrale
curò prima dell’arrivo del nuovo
vescovo, Giovan Battista Capuano
(1729 - 1748 ?), di procedere
nella costruzione utilizzando i
soldi dello spoglio. Il nuovo
presule “poco o nulla oprò”. Se
ne stette quasi sempre lontano
dalla diocesi, entrò in
contrasto con i laici, tanto che
fu minacciato con la pistola e
fu accusato di molti abusi46.
Lasciò la diocesi in mano ai
suoi ministri, ed ufficiali che
“commisero molti delitti ed
eccessi” , tanto che il papa
Benedetto XIV, accogliendo le
proteste dei diocesani, dovette
inviare il visitatore
apostolico47 . Finiti i soldi
dello spoglio. La cattedrale ed
il palazzo vescovile, avendo
questi bisogno di restauro fin
dalle fondamenta, rimasero
imperfetti, occorrendo altri
sussidi, perché le rendite della
chiesa di Belcastro sono
tenui48.
Scossa e lesionata dal terremoto
del dicembre 1744 che aveva
danneggiato i luoghi sacri “ita
ut in pluribus locis ecclesiae
aedificia appellari possunt
maceriae”. Il vescovo pochi mesi
dopo affermava di aver tutto
restaurato e che la cattedrale
era decentemente ornata e
provvista di ogni cosa e così
tutte le chiese della città e
della diocesi, soggette alla sua
giurisdizione49 .
Dopo il breve vescovato di
Giacomo Guacci (1748 - 1754),
salì sul trono vescovile di
Belcastro Tommaso Fabiani (1755
- 1778).
A metà Settecento la diocesi si
estendeva per 50 mila passi in
latitudine ed in longitudine,
comprendeva oltre alla città di
Belcastro, in continuo degrado,
i tre villaggi di Castrum de
Aragonia, detto anche Andali,
abitato da 550 Albanesi, S.
Angelo in Cuturella con 206 e La
Cerva con 340 abitanti. Il
vescovo dovette subito risanare
la sede vescovile che minacciava
rovina, sia per il soffitto
ligneo, che era marcio, sia per
le pareti che rovinavano. A sue
spese, poiché dallo spoglio del
suo predecessore niente ricavò,
cominciò a ricostruire il coro
dalle fondamenta più ampiamente,
più degno, e più alto,
comprendente tre ordine di
sedili.
Nel 1761 esso era completato e
gli stalli erano già stati
ornati. Eresse inoltre tre nuove
edicole dedicate all’Immacolata,
a S. Tommaso D’Aquino ed a San
Francesco D’Assisi. Così è
descritta la cattedrale nella
sua relazione del 1758. La
cattedrale ha la porta maggiore
rivolta ad occidente, mentre la
minore è sul lato
settentrionale. Un breve spazio
la separa dal palazzo vescovile.
Il vescovo la congiunse
all’episcopio ed al seminario.
Essa è divisa in tre navi, la
maggiore centrale e due
laterali, tutte ben costruite,
ornate e coperte con soffitti
lignei a cassettoni.
La navata maggiore è illuminata
da finestre che sono situate,
tre per ogni lato, il resto è
rischiarato da un’altra finestra
di maggiore ampiezza, che si
apre sulla parete del coro.
Le navate laterali ricevono
inoltre luce anche da due altre
finestre. L’altare maggiore
dedicato a San Michele Arcangelo
è situato davanti al coro, il
quale è sotto un’arcata troppo
opprimente. Perciò affinché i
canonici non patissero disagi e
la casa di Dio rispecchiasse la
sua potenza, mi sembrò opportuno
allargare il coro ed innalzare
la volta. Così ogni parte
dell’edificio avrebbe assunto
una forma più conveniente e
razionale. Tale opera con passo
celere sta ora per essere
conclusa. Nel corno
dell’Evangelo davanti al detto
altare maggiore, si eleva il
trono vescovile, al quale si
accede per tre gradini di legno.
Esso è dotato di ombrella di
seta ed il sedile è coperto con
un panno di seta dai colori
banco e rosso.
Più in basso è situato uno
scanno per gli eletti del
governo cittadino di Belcastro e
ci sono pure altri scanni
necessari per ascoltare la
predica.
Presso la porta maggiore da una
parte c’è la fonte battesimale,
costruita in pietra verde. Essa
è rinchiusa in una cappelletta
di modesto graticcio ligneo.
Nella parte superiore della
navata laterale destra è situata
la cappella dello SS.mo
Sacramento, di aspetto elegante
e decorata con un tabernacolo
ligneo dorato. Vi ardono sempre
due lumi e nei giorni più
solenni si accende il fuoco in
un altro lume d’argento, che io
assieme ad una sfera feci
ripristinare da un bravo
artigiano napoletano,
spendendoci 150 ducati.
I ricchi censi di questa
cappella sono amministrati da un
idoneo procuratore
ecclesiastico. Dapprima nella
parete laterale troviamo
l’altare dedicato a Sant’Antonio
da Padova, al quale è annesso il
beneficio di iuspatronato della
famiglia dei Gargano ; il frutto
di questo beneficio assomma a 90
ducati annui con l’onere di 200
messe.
Più sotto nella stessa navata si
trova l’altare dello SS.mo
Sangue di Cristo di iuspatronato
della famiglia dei Bellatori, al
quale è congiunto e fondato un
beneficio di 30 ducati di
rendita.
Quarto ed ultimo altare di
questa navata è quello dedicato
all’Immacolata, la cui sacra
icone è venerata e curata dal
popolo. Questo altare fu
trasferito dalla chiesa di San
Francesco, che fu soppressa al
tempo della sua visita da Nicola
Abbate, vescovo di Squillace. In
seguito vi fu fondato sotto tale
titolo il beneficio laicale
della famiglia dei Sillano, che
gode di un piccolo censo.
Nella parte superiore della
navata sinistra, che è di forma
non dissimile, c’è la cappella
dello SS.mo Crocifisso, che si
sostiene con le elemosine.
Subito dopo segue nella parete
laterale, l’altare di San
Tommaso d’Aquino, nostro
protettore, col beneficio di
iuspatronato della famiglia dei
De Laudari. Tale beneficio gode
24 ducati di rendita. Nello
stesso altare c’è la statua del
santo “Dottore” che è tenuta in
grande devozione e pietà non
solo dai suoi concittadini
Belcastresi, ma anche dalle
innumerevoli genti che da luoghi
vicini e lontani, qui vengono in
pellegrinaggio nel giorno della
sua festa per assolvere i voti.
In tale giorno e quando le
calamità colpiscono questo
popolo c’è l’usanza di portarla
solennemente in processione per
la città.
Infine c’è l’altare consacrato a
San Francesco d’Assisi, altare
che fu traslato qui dalla sua
chiesa sempre dal vescovo di
Squillace.
Resta da dire solo di un altro
luogo che c’è in questa navata.
In esso per devozione di
Sant’Anna, patrona della mia
famiglia, istituii e dedicai
alla Madre della Vergine un
altro altare e vi curai far
costruire un santo simulacro,
perché sia tenuto in maggiore
devozione.
All’ingresso della chiesa
cattedrale, sopra la porta
maggiore, si trovano gli organi
pneumatici, i quali secondo
l’antichissimo rito, nei giorni
prescritti dal nuovissimo
cerimoniale di Benedetto XIV,
pulsano per opera di un valente
organista.
Da una delle navate laterali si
accede alla sacrestia, che ha
una elegante volta, due finestre
con vetri ed armadi le ornano le
pareti.
Vi erano appena le suppellettili
necessari di seta e di quei
colori, che le rubriche
prescrivono. Vi trovai solo due
paramenti pontificali preziosi,
confezionati in seta dorata, che
curarono far fare due miei
predecessori.. Prima di giungere
a questa chiesa, comprai con mio
denaro tutte le suppellettili
pontificali di tutti i colori e
tutti i libri pontificali ; cioè
paramenti solenni tessuti con
seta dorata e feriali,
confezionati con seta d’argento
e violacea. Comprai inoltre una
pianeta, una mitra ecc.
All’esterno della chiesa si
innalza il campanile, nel quale
ci sono tre campane : la
maggiore, la mediana e la
minima. Esse producono un ottimo
concerto50.
Nel 1761 esso era completato e
gli stalli erano già stati
ornati. Eresse inoltre tre nuove
edicole dedicate all’Immacolata,
a S. Tommaso D’Aquino ed a San
Francesco D’Assisi51.
Rifece poi il capellone
dell’altare maggiore, l’organo e
l’orchestra52. Nonostante i
buoni propositi, giorno dopo
giorno, come tutti gli edifici
della città, la situazione va
peggiorando, come se una
pestilenza col tempo tutto
pervada e corroda53. Il vescovo
interviene di nuovo e rifà la
cappella dello SS. Corpo di
Cristo che era completamente
deturpata.La restaura e la
riduce in forma più elegante,
costruendovi una nuova volta in
gesso. Vi erige in essa un nuovo
altare con tabernacolo ed
ostensorio e la decora
magnificamente con marmi,
arricchendola di croce, fiori,
candelabri ed altri ornamenti,
spendendovi oltre 800 ducati54.
Alla sua morte la sede vescovile
rimase vacante per 14 anni55.
Essa fu amministrata da Giuseppe
Fragale di Andali, un semplice
canonico che era stato elevato
dal Fabiani ad arcidiacono56.
Alla fine del Settecento la
diocesi di Belcastro si
arricchisce del nuovo villaggio
agricolo di Botricello. Il
vescovo Vincenzo Greco di
Crotone (1792 - 1807) descrive
la cattedrale come un edificio
abbastanza elegante e
sufficientemente ampio e adatto
per la popolazione. Egli nel
1794 fa rifondere due delle tre
campane e restaura il campanile.
Fornisce inoltre la chiesa di
molte sacre suppellettili57.
Dopo la sua improvvisa morte,
avvenuta in Crotone, si
avvicendarono
nell’amministrazione della
diocesi Luigi Maiorana, Luigi
Gimigliano, Giovan Francesco
d’Alessandro e da ultimo il
vicario apostolico Carmine de
Grazia, il quale resse l’ufficio
fino al 1818, quando la diocesi
passò sotto l’amministrazione
dell’arcivescovo di Santa
Severina58. Infatti dopo il
Concordato del 16 febbraio 1818
tra Pio VII e Ferdinando IV, una
bolla pontificia del 27 giugno
di quello stesso anno stabiliva
la nuova organizzazione
ecclesiastica della Calabria. Il
titolo vescovile della chiesa di
Belcastro fu soppresso e la
città e la diocesi furono
aggiunte ed aggregate alla
chiesa arcivescovile di Santa
Severina. Soppresso il titolo di
cattedrale, la chiesa di San
Michele Arcangelo fu ridotta ad
insigne collegiata.
Note
1. Russo F., Storia della
chiesa cit., I, pp.200 sgg.
2. Siberene, p.16.
3. La città avrebbe mutato nome
al tempo di re Roberto d’Angiò,
quando nel 1330 fu infeudata
come contea ai d’Aquino, Russo
F., Regesto, I, pp.87 sgg. ; Rel
Lim. Bellicastren., 1699, 1703.
4. Della presenza degli Ebrei
ancora nel Settecento rimanevano
rilevanti tracce del loro
insediamento nella città, Rel.
Lim. Bellicastren., 1703.
5. Russo F., Regesto, I, 173,
sgg.
6. Tracce di questa
organizzazione la ritroviamo
ancora nel Settecento. Allora
l’arcidiacono aveva unita la
cura della chiesa di Santa Maria
delle Grazie, il cantorato
quella di S. Maria Maddalena,
l’arciprete quella di S. Nicola,
il canonico degli SS. Jacobo e
Lucia la chiesa dedicata ai
santi, i canonici della SS.
Annunciazione, di S. Maria de
Sanitate e di S. Paolo avevano
solo il titolo senza più le
chiese e così il canonico di S.
Pietro che aveva la cappella
dentro la chiesa di S. Maria
della Pietà, Rel . Lim.
Bellicastren. 1707, 1758.
7. L’arciprete era stato
istituito nel 1578 e poi
confermato nel 1597, Rel. Lim.
Bellicastren., 1634.
8. Rel. Lim. Bellicastren.,
1597.
9. Fiore G., Della Calabria
Illustrata, II, 334.
10. Fiore G., Della Calabria
Illustrata, II, 334.
11. Epigrafe : “S. D. GREGORII
XIII/ PRIVILEGIO QUOT/ MISSAE
DEFUNCTOR./ IN HOC ALTARE OFFE=/
RUNTUR TOTANIMAE PUR=/ GATORII
PENIS LIBERAN/ TUR IO. AN. D.P.
EPUS/ BELLICASTREN. 1583”
12. Rel. Lim. Bellicastren.,
1592.
13. Rel. Lim. Bellicastren.,
1597.
14. Russo F., Regesto, IV,
(18618)
15. Rel. Lim. Bellicastren.,
1603 ; Dai 593 fuochi del 1545
nel 1561 era scesa a 221 e nel
1595 veniva tassata per 246.
16. Rel. Lim. Bellicastren.,
1612.
17. Rel. Lim. Bellicastren.,
1620.
18. Rel. Lim. Bellicastren.,
1603.
19. Il vescovo trovò alcune
terre della chiesa occupate ed
lo “jus vendendi spicas”
usurpato, Rel. Lim.
Bellicastren., 1620.
20. Rel. Lim. Bellicastren.,
1620.
21. Rel. Lim. Bellicastren.
1625.
22. Epigrafe: “ QUAM./ NICOLAUS.
ANTONIUS./ SCARRILLO./ NOBILIUM.
SINDICUS. HIC./ ANNO (I) (I
CXXXII./ MAGISTRATUS. SEDEM.
LOCAVIT./ VETUSTATE. COLLAPSAM./
D. NICOLAUS GIMIGLIANO CIVITATEM
GERENS./ PERILLUSTREM./
SPLENDIDIOREM. HANC. IN.
FORMAM./ CURUS. PLAUDENTIBUS.
INSTAURAVIT./ NONIS. MARTII
(I)(ICCLXXIX”
23. Russo F., Regesto, VI, 315.
24. Il vescovo Bartolomeo Gizio
chiede al papa di potersi
assentare dal 15 luglio al primo
ottobre e dal 15 dicembre al 15
febbraio di ogni anno, Rel. Lim.
Bellicastren., 1634.
25. La città era abitata da
circa 900 abitanti dei quali 28
preti, 3 suddiaconi e 43
chierici, Rel. Lim.
Bellicastren., 1634.
26. Il vescovo Giptio mosse lite
ad alcuni cittadini di Catanzaro
e di Belcastro i quali fin dal
1633 pagavano le decime non al
vescovo ma ai parroci dei luoghi
in cui i beni si trovavano, Rel.
Lim. Bellicastren., 1637.
27. Il vescovo Giptio poiché
alcuni cittadini, protetti dal
feudatario di Magliacane, Cesare
Maricola di Catanzaro, non
volevano pagare le decime , li
scomunica, Rel. Lim.
Bellicastren., 1637.
28. Rel. Lim. Bellicastren.,
1641.
29. Rel. Lim. Bellicastren.
1645.
30. Russo F., Regesto, VII, 316.
31. Rel. Lim. Bellicastren.,
1665.
32. Rel. Lim. Bellicastren.,
1673.
33. Russo F., Regesto, IX,
(45182), (45483).
34. Rel. Lim. Bellicastren.,
1692.
35. La comunità di Belcastro
aveva avuto dal papa per
riparare le rovine duc.600 che
dovevano essere applicate con il
consenso del vescovo e dei
sindaci ed il parere dei
cappuccini di Cropani. La somma
consegnata dal nunzio al vescovo
dopo quattro anni non era stata
ancora spesa, Nunz. Nap. 112,
f.297.
36. Rel. Lim. Bellicastren.,
1699.
37. Rel. Lim. Bellicastren.,
1703.
38. Rel. Lim. Bellicastren.,
1707, 1718.
39. Rel. Lim. Bellicastren.,
1726.
40. Russo F., Regesto, X,
286,350.
41. Russo F., Regesto, X, 328.
42. Russo F., Regesto, X, 364.
43. Russo F., Regesto, 368, 369.
44. Rel. Lim. Bellicastren.,
1727.
45. Capialbi V., La
continuazione dell’Italia Sacra
dell’Ughelli per i vescovadi di
Calabria, Arch. Stor. Della
Calabria, II, 1914, p.196.
46. Il vescovo fu minacciato con
la pistola da due laici, ed è
accusato di starsene a Napoli e
di abusi sulle ordinazioni,
Russo F., Regesto, XI, 36, 238,
339, 355.
47. Capialbi V., cit., p.197.
48. Russo F., Regesto, X, 404.
49. Rel. Lim. Bellicastren.
1745.
50. Rel. Lim. Bellicastren.,
1758.
51. Rel. Lim. Bellicastren.,
1761.
52. Capialbi V., cit., p.198.
53. Rel. Lim. Bellicastren.,
1771.
54. Rel. Lim. Bellicastren,
1775.
55. Capialbi V., cit., p. 198.
56. Rel. Lim. Bellicastren.,
1768.
57. Rel. Lim. Bellicastren.,
1795.
58. Capialbi V., cit., p.199.
Il
convento domenicano di Belcastro
di Andrea
PESAVENTO
(pubblicato su La Provincia KR
nr. 19/2003)
Il primo
convento domenicano in diocesi
di Belcastro fu edificato sotto
il titolo di Santa Maria della
Grazia. Esso era situato a circa
due miglia di distanza dalle
mura della città in località
“Forestella”. Secondo il Fiore
alla sua costruzione
contribuirono i cittadini del
luogo Gio. Alfonso e Stefano
Pugliesi. L’anno in cui avvenne
è indicato dallo stesso Fiore
nel 1393. Non concorda sulla
data di fondazione una relazione
della metà del Seicento stesa
dai domenicani di Belcastro, i
quali rifacendosi a presunti
documenti esistenti nel
convento, ma alla prova di
dubbia autenticità, pongono la
fondazione del convento al 1451.
Il nuovo convento
Se è controversa la data di
fondazione del primo convento
domenicano di Belcastro, è
invece sicuro che in seguito i
domenicani lasciarono il vecchio
convento troppo lontano dalla
città e si trasferirono in uno
nuovo vicino alle mura. Ciò
avvenne secondo il Fiore nel
1480. Secondo la relazione
seicentesca la data di presa di
possesso, questa volta ben
documentata, del nuovo convento
è fissata al 1491. L’abbandono
evidentemente avvenne a causa
del pericolo turco ed il nuovo
convento venne intitolato a San
Domenico1. Così è descritto in
una relazione il trasferimento
nel nuovo convento: " L'anno
1491 fu trasferito d(ett)o
con(ven)to per la distansa et
commodità delli cittadini; et fu
impetrato breve Apostolico di
Papa Innocentio ottavo come
appare sotto la d(at)a delli 22
di luglio del anno 1491
sigillato col sugello di piombo,
et cordella di canape; facendo
espressa mentione della bolla di
Bonifatio ottavo, che non
ostante detta bolla si possa
trasferire il d(ett)o
monasterio, et ridursi vicino la
città in distansa di tre canne
sotto il titulo di Santo
Dom(eni)co, con il consenso
della citta, et mediante
instrumento li fu concesso
questo luoco"2.
Alla fine del Cinquecento in
diocesi di Belcastro troviamo
tre piccoli conventi: "uno di S.
Domenico, l'altro di S.
fran(ces)co delle scarpe l'altro
di terziari di S. fran(ces)co3.
Secondo le relazioni dei vescovi
di Belcastro di quel periodo
tutti e tre sono abitati da
pochi frati: quello domenicano
da tre o quattro sacerdoti,
quello dei conventuali da due e
quello del terzo ordine di S.
Francesco da uno o due
sacerdoti4.
Alla metà del Seicento
Al tempo del vescovo
Francesco Napoli (1639 – 1651)
tra i tre conventi esistenti in
diocesi di Belcastro, quello
domenicano è il più importante,
sia per rendite che per il
numero di frati che ospita. Esso
infatti, secondo il vescovo, può
contare su una rendita annua di
oltre cinquecento ducati, mentre
quello dei conventuali ne ha
circa duecento e quello della
SS. Trinità dei terziari
francescani solo settanta; il
primo ospita, o può mantenere,
dodici frati mentre negli altri
ce ne sono solo due o tre.
Inoltre il convento domenicano
svolgeva una meritoria attività
culturale a favore dei frati e
dei cittadini in quanto "in eo
est erectum studium philosophiae
in fratruum et secularium
commoditatem"5.
Per tale motivo a Belcastro solo
i domenicani riusciranno a
passare indenni dalla
soppressione dei piccoli
conventi, prevista dalla
Costituzione Innocenziana, come
evidenzia il vescovo Carlo
Sgombrino: " Non ci sono in
detta città monasteri femminili
ma uno solo maschile dell'ordine
dei predicatori perché gli altri
due, cioè quello di San
Francesco dell'ordine dei
conventuali e quello della SS.ma
Trinità del terzo ordine di San
Francesco, furono soppressi in
vigore della Bolla di Innocenzo
X"6.
Nel 1650 la "famiglia"
domenicana di Belcastro infatti
risultò composta da sei
componenti, il numero appena
sufficiente per sfuggire alla
soppressione. Nel convento vi
erano tre sacerdoti (il priore
fra Domenico Zito, il sacerdote
fra Gio. Battista di Soriano ed
il lettore fra Giacinto di
Zagarise), due fratelli laici
professi ( fra Domenico di
Soriano e fra Pietro di
Mesoraca) ed un serviente laico.
Si sa che alla metà del Seicento
i frati ripararono il monastero.
Per far ciò essi dovettero anche
indebitarsi per ducati sessanta
per riparare "l'intempiata".
Allora la costruzione era
composta dalla chiesa dedicata a
San Domenico, che era lunga
palmi settanta e alta quaranta,
e da due dormitori con
quattordici stanze; inoltre vi
erano delle "officine" situate
nei bassi. Il convento era
chiuso da mura vicino alle quali
vi era l’orto con alberi
fruttiferi. I frati possedevano
numerosi terreni di varia natura
e di diverso uso, che davano in
fitto. Tra i più redditizi erano
quelli adatti alla semina, che
di solito erano affittati tre
anni a semina e tre a pascolo.
Essi erano situati in località
“Crina”, “L’acqua della Fico”,
“Il Cavalcatore”, “Furca”, “La
Cona”, “Drialo” e “Juani Marra”.
Vi erano poi quelli adatti solo
al pascolo, che erano in
località detta “La Cubica o
Chiubica”. A ricordo di dove
anticamente sorgeva il primo
convento, i domenicani
conservavano una vigna ed un
territorio boschivo in località
La Forestella. Vi era poi la
“possessione” con alberi
fruttiferi detta “La Torre di
San Domenico” e la vigna con
alberi da frutto di “Campia”. A
questi terreni era da aggiungere
un castagneto ed un oliveto. In
passato numerosi piccoli fondi
erano stati concessi in
enfiteusi a coloni del luogo,
previo il pagamento di un censo
perpetuo annuo. Dai censuari al
convento proveniva ogni anno 40
tomoli di grano e 168 ducati.
Altri 45 ducati versava
l’università di Belcastro alla
quale i frati avevano ceduto la
mastrodattia. Completavano le
entrate i proventi del mulino e
le elemosine al tempo della
raccolta in grano, denaro, olio
ecc. e quelle per funerali, cera
ed altro. I domenicani di
Belcastro stimavano l’entrata
annua calcolata sugli ultimi sei
anni in circa 357 scudi romani,
mentre l’uscita in 337 scudi.
Anche se le entrate erano
sottostimate, in quanto da altre
fonti si sa che erano di solito
abbondantemente superiori ai
cinquecento ducati annui, e
all’opposto le uscite erano
state gonfiate, il convento
risultò attivo. Quasi la metà
delle entrate proveniva da
censi, segno che col passare del
tempo tanti terreni non erano
più amministrati dal convento,
ma erano definitivamente passati
ai privati. Per amministrare il
rimanente che veniva affittato,
bastava di solito la presenza di
due o tre frati. Tra le uscite
primeggiavano le spese per il
vitto e per il vestiario dei sei
religiosi, che da sole
rappresentavano i tre quarti del
totale, seguivano quelle per il
mantenimento del somaro, per il
serviente, per il consueto ed
ordinario mantenimento della
chiesa e del convento, per le
medicine, per il pagamento di
alcuni censi passivi, per le
contribuzioni all’ordine ecc7.
Liti con i vescovi
Tuttavia nonostante questa
discreta floridezza e forse per
tale motivo, alla fine del
Seicento il vescovo Giovanni
Emblaviti (1688 – 1722) ne
chiese la soppressione,
adducendo che era piccolo e che
i monaci non osservavano le
regole. Esso inoltre secondo il
vescovo non era consono alle
prescrizioni previste dalla
bolla papale, in quanto aveva
poche rendite e di solito non vi
abitavano i sei frati previsti,
ma solo due monaci sacerdoti e
tre conversi, ossia oblati.
Facendosi forza su queste
accuse, il vescovo sollecitava
un intervento papale in modo da
estinguere il convento
domenicano, per poterne
incamerare ed amministrarne le
rendite, con il pretesto di
assegnarle per il seminario8. La
lite tra il vescovo Emblaviti ed
i domenicani si prolungò. Il
presule proseguì nel suo
tentativo, denigrando di
continuo il convento ed i frati
che vi abitavano; descrivendo il
luogo privo di una regolare
osservanza e la vita dei frati
non rispondente ai principi
religiosi, pietra di scandalo
per i cittadini e continua
occasione di offesa per il
vescovo. L'Emblaviti si premurò
di informare di ciò anche il
provinciale dell'ordine,
invitandolo ad intervenire per
riportare i domenicani di
Belcastro sulla retta via9.
La conflittualità tra il vescovo
ed i domenicani si prolungò
durante tutto il lungo periodo
in cui l'Emblaviti rimase sulla
cattedra vescovile di Belcastro,
trovando più volte occasione di
accendersi pubblicamente.
All'inizio del Settecento il
vescovo interveniva contro i
frati, perché si erano permessi
di erigere senza il suo consenso
una confraternita laica sotto il
Nome di Gesù, che si era
aggiunta a quella già esistente
del Rosario. Le due
confraternite ben presto vennero
a lite dentro la chiesa,
suscitando tra i cittadini
occasione di grande scandalo.
Prendendo spunto da tale
avvenimento l'Emblaviti minacciò
i frati a non istituire nuove
confraternite senza il suo
consenso e proibì ai laici di
parteciparvi. Poiché i
domenicani opposero il fatto di
godere per licenza papale di
tale diritto, il vescovo
richiese un parere alla Sacra
Congregazione. La conflittualità
tra il vescovo ed i domenicani
si prolungò durante tutto il
lungo periodo in cui l'Emblaviti
rimase sulla cattedra vescovile
di Belcastro10.
Anche se i frati si opposero
tenacemente, l'Emblaviti
proseguì nel tentativo di porre
il convento sotto la sua
giurisdizione e più volte
nonostante le proteste lo
sottopose a visita11. A causa
della cattiva amministrazione
proseguiva la perdita dei beni
del convento. E’ di questi anni
un intervento del papa Clemente
XI il quale il primo maggio 1719
si rivolgeva ai vescovi di
Belcastro, Isola e Catanzaro o
ai loro vicari generali affinché
intervenissero a favore del
priore e del convento domenicano
per recuperare e far restituire
i beni sottratti12. Se da una
parte i frati tentavano di
recuperare i beni sottratti
illecitamente dall’altro
dovevano fronteggiare i
tentativi vescovili.
Il successore dell'Emblaviti,
Michelangelo Gentile (1722 -
1729), rivolgendosi alla Sacra
Congregazione, affermava che
"....poiché manca il numero di
sei religiosi come previsto dal
decreto "Ut in parvis" di
Innocenzo X, non vi è dubbio che
essi debbano soggiacere alla
correzione e alla visita del
vescovo, come in effetti il mio
predecessore ha fatto. Anch'io
in conformità dello stesso
decreto curerò visitarlo, in
quanto al presente manca una
regolare osservanza ed ha
bisogno di essere riformato dal
profondo. Comunque chiedo un
Vostro responso"13. Stretti
dalla soggezione vescovile, i
domenicani cercarono di opporsi
aumentando i componenti della
"familia" ma il vescovo ribadì
che non vi vigeva una regolare
osservanza e che anche se vi era
un numero sufficiente, cioè
quattro sacerdoti e due laici,
essi non risultavano conformi al
decreto "Ut in parvis", non
essendo di provata vita
religiosa e di età matura.
Perciò il convento rimaneva
soggetto alla sua
giurisdizione14.
Verso la soppressione
L'ostilità vescovile riprese
al tempo del vescovo Tommaso
Fabiani (1755- 1778): "Nella
città di Belcastro c'è il solo
convento dell'ordine dei
predicatori, che dapprima fu
fondato nel luogo detto S. Maria
de Forestella, a circa un miglio
di distanza dalla città. Dopo fu
trasferito entro le mura della
città, dove attualmente si
trova. Esso ha una rendita annua
eccedente i 400 ducati, ma
nonostante ciò a causa della
cattiva amministrazione i
religiosi vivono parcamente. Vi
abitano due o al massimo tre
frati e due laici, o conversi,
che d'estate a causa dell'aria
perniciosa, si trasferiscono
altrove, lasciando solo un laico
a custodire il convento. Secondo
la Costituzione di Innocenzo X è
soggetto alla giurisdizione
vescovile, anche se i miei
predecessori hanno trascurato di
visitarlo"15.
Al tempo della soppressione dopo
il terremoto del 1783 nel
convento vi erano solo tre
monaci16.
La soppressione definitiva
avverrà durante il Decennio
francese17.
Note
1. Fiore G., Della Calabria
cit., II, 391.
2. Relatione del Con.to di San
Dom.co di Belcastro, S. C. Stat.
Regul., Relations, 25, ff. 751
-755, Arch. Segr. Vat..
3. Rel. Lim. Bellicastren. 1592.
4. Rel. Lim. Bellicastren.,
1603.
5. Rel. Lim. Bellicastren.,
1645.
6. Rel. Lim. Bellicastren.,
1665.
7. Relazione del Con.to cit.
8. Rel. Lim. Bellicasren., 1692.
9. Rel. Lim. Bellicastren.,
1699.
10. Rel. Lim. Bellicastren.,
1703
11. Rel. Lim. Bellicastren. 1718
12. Russo F., Regesto, 53774.
13. Rel. Lim. Bellicastren.,
1727.
14. Rel. Lim. Bellicastren.,
1735.
15. Rel. Lim. Bellicastren.,
1758.
16. Vivenzio G., Istoria e
teoria de’ tremuoti, Napoli
1783, (14).
17. Caldora U., Calabria
napoleonica (1806 -1815) cit.,
p. 221.
***
Le entrate del convento di San
Domenico di Belcastro come
risultano in una relazione fatta
il 7 marzo 1650 e sottoscritta
dal priore Domenico Zito e dai
frati Gio. Battista Soriano e
fra Giacinto di Zagarise.
Il Monasterio di San.to Dom.co
del Ordine di pred.ri situato
nella citt.a di Belcastro
primieramente fu edificato fuori
della città sotto il titulo di
Santa Maria della gratia
distante della città due miglia
l'anno del sig.re mille quattro
cento cinquantuno con il
consenso di Papa Alessandro
sesto come per breve, con il
sugello di piombo con cordella
di canape fu questo assenso
inpetrato dalla Università et
populo et dimororno li frati in
questo monasterio in sino l'anno
mille quattro cento novant'uno.
L'anno 1491 fu trasferito d.o
con.to per la distansa et
commodità delli cittadini; et fu
impetrato breve Apostolico di
Papa Innocentio ottavo come
appare sotto la d.a delli 22 di
luglio del anno 1491 sigillato
col sugello di piombo, et
cordella di canape; facendo
espressa mentione della bolla di
Bonifatio ottavo, che non
ostante detta bolla si possa
trasferire il d.o monasterio, et
ridursi vicino la città in
distansa di tre canne sotto il
titulo di San.to Dom.co, con il
consenso della citt.a, et
mediante instrumento li fu
concesso questo luoco.
Ha la chiesa sotto titulo et
invocatione di Santo Dom.co.
E di struttura d.a chiesa da
palmi settanta di lunghezza et
da quaranta di altezza tiene dui
dormitori con quattordici
stanze, et officine nelli bassi.
Al presente dimorano di famiglia
sei cioè tre sacerdoti: Il P.
fra Dom.co Zito Priore, il P.
fra Gio. batt.a di Soriano
sacerdote, Il P. fra Giacinto di
Zagaresi lett.re, dui fratelli
laici professi cioè fra Dom.co
di Soriano, et fra Pietro di
Mesoraca, et un altro serviente
laico seu famulo.
Possiede il d.o monasterio
terreni lavorativi in più e
diversi luochi del territorio li
quali si chiamano in questo
modo:
Nel territorio di Crima due
pezzi di terreni di tumula vinti
per ciaschedun pezzo li quali
fatti il computo da sei anni in
qua rendono per ciaschedun anno
scuti di camera dudici
Item un altro pezzo di
territorio loco detto l'acqua
della fico di tumulate vinti
quale fatto il computo da sei
anni in qua si trova che ogni
anno rende scuti di camera sei.
Item un altro pezzo di tumulate
vinti loco detto il cavalcatore
se ne riceve ogni anno scuti di
camera 6.
Item un altro pezzo di terreno
di vinti tumulate loco detto
furca fatto il calculo di sei
anni ut supra se ne riceve ogni
anno scuti di camera 6
Item tre altri pezzi di terreni
uno loco ditto la cona l'altro
Drialo et altro juani marra da
tumuli otto l'una li quali ogni
anno ne riceve da tutti tre
scuti di camera 6
Quali terreni si vendono in
erbaggi. Item dui altri pezzi di
terreni loco detto La Cubica seu
Chiubica da vinti cinque
tumulate delle quali il con.to
ne sole ricevere un anno per
altro da sei anni in qua scuti
dui di camera. 2.
Item possiede tumula quaranta di
grano ogni anno da diversi
censuarii in perpetuum quali
s'apprezzano un anno per l'altro
scuti di camera vinti sei et
pauli diece.
Item possiede una vigna loco
detto La forestella la quale
rende in vino al con.to scuti
duoi di camera. 2.
Item nella detta Forestella
possiede un territorio di boscho
si affitta per erbaggio l'un
anno per l'altro scuti sei. 6
Item possiede una possessione
loco detto la torre di San.to
con celsi et altri arbori
fruttiferi, et non fruttiferin
rende al con.to l'un altro per
l'altro scuti cinque 5.
Item possiede una altra vigna
con alberi fruttiferi, loco
detto Campia la quale rende al
con.to scuti tre. 3.
Item tiene un orto vicino le
mura del con.to con celsi, et
altri arbori fruttiferi il
monastero ne riceve ogni anno
per affitto scuti sette. 7
Item possiede un molino da grano
dal quale si recevono tumula di
grano quaranta otto delle quali
levatene le spese delle pietre,
et altri acconci restano al
con.to scuti di camera vintitre
(23).
Item possiede un castagnito dal
quale sene riceve ogni anno in
affitto scuti duoi . 2,
Item possiede un oliveto che
l'un anno per l'altro si
affitt.a un scudo.
Item possiede diversi censi da
vari et diversi censuarii in più
e diverse partite scuti di regno
168 redutti in scuti di camera
ogni anno ne riceve scuti cento
et dudici (112).
Item possiede dall'università
della d.a citt.a di Belcastro
ogni anno per un cambio della
mastrodattia scuti di regno
quarantacinque che redutti a
scuti di camera sono scuti
trenta (30).
Item suol cavare da elemosine
incerte ma consuete di diversi
benefattori oglio, pane, grano,
denari che riducendo il tutto a
moneta romana raguagliando
l'anni come sopra ascende a
scuti 6.
Item suol cavare di funerali et
per la cera et elemosine da
scuti tre di camera (3)
16 ottobre 2010
 |